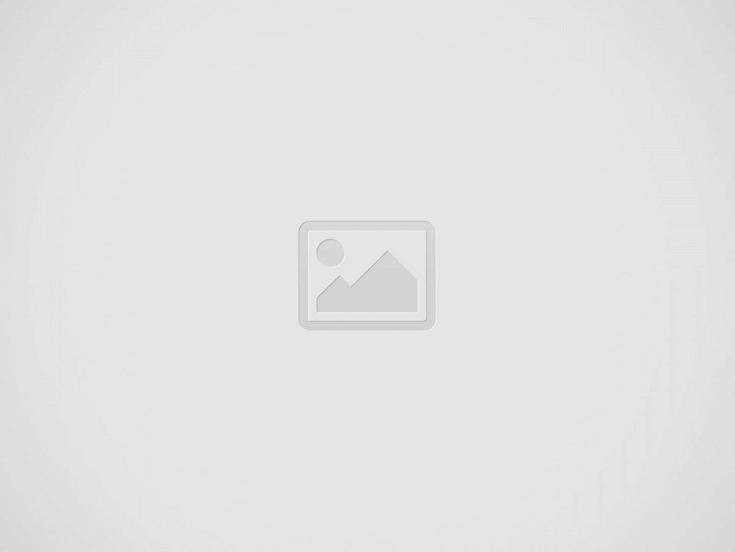La recensione di The Post di Steven Spielberg: l’ultimo sguardo al sistema giornalistico si dimostra perfetto e incalzante, sensibile ai dilemmi interiori di una donna. Steven Spielberg resta uno dei più grandi registi statunitensi di sempre
The Post – La recensione di Zon.it Ci sembra così lontano il 2012. Eppure, proprio in quell’anno,
l’Hbo firmò il suo contratto con
Aaron Sorkin per
The Newsroom, serie poi conclusasi dopo il suo terzo anno, tra episodi mastodontici ed altri traballanti.
Il giornalismo era finalmente approdato in televisione. Aaron Sorkin era uno degli sceneggiatori più acclamati, uscito direttamente dall’
Oscar per
“The social Network” di
David Fincher, autore di film come
“L’arte di vincere” di
Bennett Miller. Bisognerebbe andare ancor più lontano, pensando al
“Network” di Sidney Lumet del 1975, in Italia arrivato con il titolo italiano di
“Quinto potere” citando
Orson Welles. Tra magistratura prepotente complice del giornalismo arrivista, usi spregiudicati dell’informazione televisiva e impazzimenti da share in tempi in cui i dibattiti erano ancora giovani, potremmo continuare all’infinito, perché sì, i film sul giornalismo sono davvero tanti.
L’arte di raccontare il giornalismo al cinema
In film o serie TV dove, come in “The Newsroom” e “Network”, più che il giornalismo a farla da padrone
erano gli isterismi, le idiosincrasie di tante menti messe assieme per un fine comune, tra grida, presagi, fustigazioni, martirio e violenza della parola, si finiva per non guardare più a quel mestiere ironicamente sportivo che era il giornalismo. Lo si credeva piuttosto così, idilliaco sì, ma isterico, dove anche la svendita del proprio corpo faceva parte di un gioco per un obiettivo più grande, quello di “sbattere il mostro in prima pagina”. L’America ha fatto questo parlando di giornalismo, ha istigato la parola, non l’ha mai ridotta al suo uso privilegiato, ma l’ha violata del proprio senso. Innescando continuamente liti di supremazia, fino ad arrivare alle mani. Che sia comunque un modo di raccontare le tensioni, che sia un modo di far confluire sentimenti, vite, pulsioniì in un habitat lavorativo così problematico, dove tutto deve essere venduto bene, non può che essere comprensibile. Da qui, però, a renderlo un etichetta e un marchio per parlare ancora e ancora di
giornalismo sempre con le stesse dovizie pretestuose, borderline e con la solita cantilena ci sembra più privazione di idee e un privilegiare toni al fine di accattivare il pubblico senza un vero messaggio. Il cambiamento sostanziale degli ultimi anni
Sembra però, che le cose siano un po’ cambiate, da quando, nel 2015
Tom McCarthy portò al cinema “Il Caso Spotlight“. La storia di come il
Boston Globe rivelò – con
un’inchiesta alla vecchia maniera, forse l’ultima del suo genere già nell’epoca digitale – lo scandalo dei preti pedofili a Boston. Ma anche la storia di come lo stesso giornale l’aveva trascurata. Di sei nomination, ha vinto due Oscar, tra cui il più importante per il miglior film. Assenza completa di tutto ciò che può essere fruibile e fruito nella nostra epoca, uso minimo della tecnologia imperante.
Si ritornava a raccontare un altro giornalismo, quello che dietro, nascondeva un’indagine cartacea, un giallo, un investigazione tradizionale. The Post – un film sull’essenzialità della parola
The Post di Steven Spielberg, con Meryl Streep e Tom Hanks, con
Bob Odenkirk e con una sfilza di attori di alta fattura,
è quel genere di film sul giornalismo eccellente dove si parla di giornalismo senza il giornalismo cinematografico a cui noi siamo abituati. Primo perché Spielberg non si affanna mai, è più che mai pilotato dal suo stile suadente e mai estroso,
dove la parola si rigenera nelle sue sconfitte e nelle sue vittorie. Dove prima di tutto viene la verità, quella deflagrante, quella tormentata.
La parola che a volte nel cinema, ci si dimentica, è l’arma giusta per gareggiare contro i “cattivi”. Dove la narrazione e la consistenza della macchina da presa, non perdono di vista un passaggio, un personaggio, un azione, un pranzo con lunghe carrellate e brevi piani sequenza. Si lascia un interprete, se ne prende un altro, tra corridoi, senza la claustrofobia a cui siamo abituati dei luoghi malsani e ruvidi della schizofrenia delle masse colleriche. Qui c’è del polveroso che non resta mai immune alla novità e al compromesso tecnologico del mondo,
Spielberg è un grande regista, che ne ha fatto della sua scuola, e del suo cinema, senza mai essere spregiudicato, un forte luogo pragmatico. Finalizza tutto a una visione realistica ma soprattutto pratica, senza mai cedere alle epilessie meccaniche dei dialoghi,
appiattisce il numero delle parole, proclamando la loro importanza. Come un sofista dell’antichità, ragiona, per affrontare i suoi temi e i suoi spettatori senza toni ricattatori. Quando poi
la parola di Meryl Streep diventa femminile “ma” autoritaria, insieme, per la prima volta, allora capiamo benissimo, che il lessico, l’esposizione, è il sistema più facile e insieme più complesso per negare e soverchiare il maschilismo, la fallocrazia, il finto perbenismo maschile, lo spirito ricattatorio di un’epoca che ha sacrificato i sessi implodendone uno, quello più debole, per l’autorità e la violenza dell’altro. La parola, in The Post, così diventa identitaria e paritaria, e Spielberg si conferma il grande regista che è. Il regista, infine,
resta sembra quel bambino attratto dal suo gioco, non appesantisce mai i toni, guarda sempre la sua storia e il suo modo di narrarla con occhi da infante.